Luca Bertini 2022
LAGUNANDO 2022 > selezionati 2022

Nato a Pisa, sposato con un figlio.
Lavoro presso il comune di San Giuliano terme all’ufficio tecnico.
La passione per la scrittura ha attraversato varie fasi della mia vita in cui ho sperimentato varie forme compositive.
Da alcuni anni ho ripreso vecchie idee a cui se ne sono aggiunte di nuove.
Da circa vent’anni seguo una particolare costante pratica meditativa come allievo di Raja Joga.
ORTI DEI DOGI
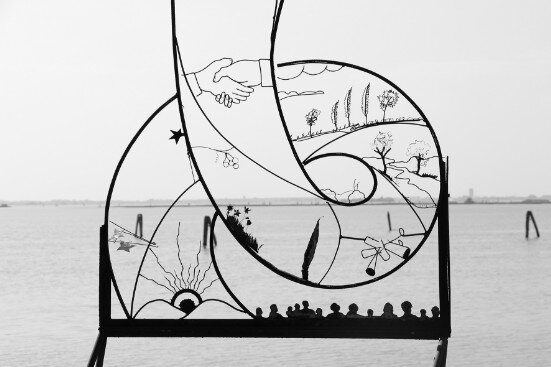
RACCONTI
ACCADDE UNA SERA A ROMA
Dopo aver attraversato il Tevere presso il ponte Sant’Angelo, arrivati proprio davanti all’ingresso dell’omonimo castello, se ci si dirigesse verso sinistra si vedrebbe lentamente disvelarsi l’ingombro di San Pietro, solenne, con la maestosa cupola a sovrastarlo e di fronte a noi un’ampia strada, diritta, che ci condurrebbe fino alla piazza delimitata dal colonnato del Bernini, dove i due lati dell’emiciclo sembrano attenderci come due braccia aperte, tanto da far pensare che quella strada ne sia il suo naturale completamento. Invece, quella soluzione non destò alcun interesse in nessuno di coloro che si succedettero alla guida del cantiere di San Pietro, a partire dal Bramante, che dette inizio all’opera, fino al Bernini che ne completò il tutto, tanto che quello spazio rimase occupato fino alla fine degli anni Trenta da un insieme di casupole, negozietti, viuzze, slarghi e palazzi come quelli che si possono trovare in tanti quartieri romani.
Di trasformazioni urbanistiche ne è piena la storia dell’architettura, e se vi chiedo la pazienza di ascoltarmi mentre mi soffermo su quella che coinvolse il quartiere da cui prese forma Via della Conciliazione, è perché in quei luoghi ebbe inizio la nostra storia.
Qualche anno prima che iniziasse la sua realizzazione vennero sottoscritti degli accordi fra il Regno d’Italia e il Vaticano, denominati Patti Lateranensi, con i quali Chiesa e Stato si riconciliavano a sessant’anni di distanza dalla presa di Roma. Negli anni che seguirono, chi era alla guida del Governo del Regno volle realizzare qualcosa che li celebrasse e non vide di meglio che edificare una strada, ampia e diritta, che avrebbe collegato Castel Sant’Angelo alla Basilica di San Pietro, a cui sarebbe stato dato il nome simbolico di Via della Conciliazione.
Pochi tocchi d’inchiostro dettero forma a quella trasformazione e il diciotto di marzo del 1932, giorno della presentazione del nuovo piano regolatore di Roma, fu lo stesso Benito Mussolini, Capo del Governo e promotore dei Patti Lateranensi, ad annunciarne la realizzazione all’interno di una serie di interventi più vasta. Ora, erano tempi nei quali il popolo italiano si stava avviando verso una visione imperiale e non poteva certo soffermarsi davanti all’ingombro di qualche casa, piazza o palazzo, oppure rammaricarsi del destino che sarebbe incorso su coloro che ci abitavano, e Benito Mussolini, che più di tutti incarnava quella propensione, in quell’occasione proclamò con una certa enfasi che il “pittoresco sudicio” sarebbe stato affidato a sua Maestà il piccone.
Il quartiere che sarebbe stato demolito in realtà non era né pittoresco e né tanto meno sudicio. Delimitato da due lunghe strade che presentavano una leggera curvatura verso l’esterno, tanto da fargli assumere la conformazione di una spina che sembrava conficcarsi all’interno del tessuto urbano, era conosciuto con il nome di “Spina di Borgo”. Di queste due strade la più ampia era quella voluta da Papa Alessandro VI per il Giubileo del 1500, che prese in seguito il nome di Via del Borgo Nuovo, in contrapposizione all’altra, più antica, che assunse quello di Via del Borgo Vecchio. Incastonata fra queste due strade vi era anche un’ampia piazza, abbellita dalla presenza di una fontana attribuita a Carlo Maderno, sulla quale si affacciava la Chiesa di San Giacomo a Scossacavalli e due importanti palazzi: quello che venne acquistato da Raffaello e in cui visse fino alla morte, conosciuto con il nome di Palazzo Caprini, e quello dei Penitenzieri, ovvero di quei canonici abilitati alla confessione in tutti quei casi che vanno oltre l’ambito dei confessori ordinari.
Di tutti gli edifici che costituivano il quartiere, soltanto in pochi trovarono scampo alla demolizione. Ci riuscì la fontana del Maderno, che dopo essere stata smontata pezzo per pezzo e riposta per una ventina d’anni nei magazzini comunali, verso la fine degli anni Cinquanta venne ricomposta ad abbellire Piazza Sant’Andrea della Valle, così come il Palazzo dei Penitenzieri che non venne neppure toccato e tutt’oggi trova posto lungo Via della Conciliazione, ma tale fortuna non toccò a Palazzo Caprini e a tutti i ricordi a cui era legato, che sotto i colpi del piccone vissero i loro ultimi giorni.
Arrivati a questo punto, non mi rimane che condurvi in un tempo in cui l’intero quartiere di “Spina di Borgo” pulsava ancora di vita, immaginandoci Roma in un giorno di metà dicembre dell’anno 1922, mentre la luce del giorno sta degradando verso il buio della sera, gravata da un cielo plumbeo, solcato da nubi scure, quasi quanto le camicie di certi ceffi che da qualche settimana si sentivano padroni della città.
L’ora è quella in cui lampionai, con le loro giubbe turchine e i loro ampi berretti con la tesa, stanno già provvedendo ad illuminare le strade, alzando le loro pertiche fino ad incoccare gli anelli che fuoriescono dalla testa del lampione per ruotare le chiavette d’accensione, e mentre Via del Borgo Nuovo e Via del Borgo Vecchio, di solito affollate da persone che entravano o uscivano dai negozietti o dagli uffici che si aprono lungo di esse, sembrano svuotate, in uno slargo prossimo a Via del Borgo Nuovo un uomo, che è appena uscito dall’ingresso laterale del Teatro Salone Elena dove si esibisce la compagnia del Capocomico Umberto Capece, cammina lentamente, quasi senza alcuna premura di tornarsene verso casa.
L’uomo ha circa vent’anni, indossa un cappotto verde di stampo militare e tiene in mano un foglio di giornale chiuso da una cordicella, come a racchiudere qualcosa messo assieme in gran fretta. I capelli scuri, impomatati, disegnano una stempiatura incipiente; il naso, pronunciato, fa una leggera curva, a raccontare di litigi giovanili; il profilo del viso è chiuso da un mento leggermente sporgente.
Dai suoi occhi scuri traspare un velo di tristezza.
Dopo aver svoltato in Via del Borgo Nuovo, l’uomo si diresse verso Castel Sant’Angelo, quasi incurante delle pozze d’acqua che durante la giornata si erano formate lungo i marciapiedi o ai bordi della strada, e proseguì fino a raggiungere Piazza Cavour. Arrivato davanti all’imponente mole del Palazzo di Giustizia percepì, in modo sempre più intenso, un odore di castagne arrostite che proveniva dal banco di una caldarrostaia, posizionata lungo la fila di platani che in quel punto costeggiavano la passeggiata sul Lungo Tevere.
Lì si fermò ad osservare i movimenti della caldarrostaia, come se trovasse in essi qualcosa d’interesse, o piuttosto come se lo distraessero da qualche pensiero, e sembrò non accorgersi che era la stessa caldarrostaia che vedeva ogni giorno mentre percorreva la strada per recarsi al Salone Elena, e dalla quale aveva pensato più di una volta di comprarsi un sacchetto di castagne per sgranocchiarsele lungo la strada di casa.
La caldarrostaia stava rigirando le castagne in una pentola che teneva sopra un bidone cilindrico, a sua volta posto su un treppiede.
Indossava un’ampia vestaglia scura che le copriva le gambe fino quasi alle caviglie, i capelli, di un nero che in alcuni punti sfumavano in lingue di grigio, erano tenuti assieme con delle forcine, mentre uno scialle di lana nero le copriva le spalle.
Appena alzato lo sguardo notò l’uomo e da subito le sembrò di riconoscere in lui un volto conosciuto. Lo osservò meglio e si ricordò che era quello di un attore che qualche giorno prima, al Teatro Salone Elena, l’aveva fatta tanto ridere con le sue smorfie, i suoi inchini, lo strabuzzare degli occhi, i movimenti delle braccia e delle gambe che lo facevano sembrare una marionetta e la capacità di allungare la testa in avanti e indietro, quasi come se fosse attaccata sul collo in modo diverso da tutte le altre teste. Mentre l’osservava si ricordò pure il nome, corto e buffo, che non aveva neppure compreso quando l’avevano annunciato dal palco per i saluti, e che per curiosità era andata a leggersi sul cartellone fuori dal teatro: Totò.
La caldarrostaia aveva una gran voglia di dirgli che l’aveva fatta tanto ridere quella sera e che tornando a casa si era pure dimenticata che quelli erano tempi in cui non c’era da ridere un granché, e solo per questo gli avrebbe voluto offrire un bel cono di castagne belle calde.
Lo osservò di nuovo e le sembrò che avesse un’aria rattristata, per cui si decise e lo chiamò.
“Totò!”.
L’uomo la guardò.
La caldarrostaia lo chiamò nuovamente.
“Totò!”
L’uomo che si faceva chiamare Totò non è che avesse una gran voglia di parlare con qualcuno, ma allo stesso tempo, in quella giornata umida e fredda, era attirato dalla possibilità di scaldarsi e magari da quella di sgranocchiare qualche castagna, che da quando era uscito da casa non aveva mangiato alcunché, per cui si avvicinò.
“Totò! Vieni qua a scaldarti.” Disse la caldarrostaia, assumendo un tono più familiare, quasi che parlasse ad un fratello minore o ad un nipote.
“Lo sai che mi hai fatto tanto ridere su quel palco! Uno dei prossimi giorni voglio tornare dal Signor Capece per ridere di nuovo a crepapelle. Ti piacciono le caldarroste?”
L’uomo che si faceva chiamare Totò fece un cenno di assenso.
“Allora, mangiane qualcuna.” Disse la caldarrostaia mentre gli passava un cono di carta gialla con dentro delle castagne arrostite.
“Sono contento che si sia divertita, ma non ci lavoro più dal Signor Capece.” Rispose l’uomo che si faceva chiamare Totò.
“Se ne è andato via?”
“No, mi ha mandato via lui.”
“Davvero?”
“Certamente.”
“Se l’ha fatto il Signor Capece è stato uno sciocco, e quant’è vero che sono la figlia di mia madre non ci ritornerò più a quel suo teatro, ma non ti devi preoccupare.”
“Perché?”
“Perché uno che fa ridere come te lo trova subito qualche altro che gli dà un posto.” Disse la caldarrostaia.
L’uomo che si faceva chiamare Totò sembrò un po’ sollevato, ma la tristezza che attanagliava il suo sguardo pareva non volersene andare, come se l’esser stato mandato via dalla compagnia del Signor Capece gli avesse scatenato altri ricordi, che ora occupavano la sua mente.
“Lo sai che diceva mio zio? Che la vita è come quando ci si fa una foto, se si sorride viene meglio”.
L’uomo sorrise e la caldarrostaia a vederlo sorridere tirò giù una gran risata.
Quelle castagne lentamente cominciarono a riscaldargli l’animo oltre a saziargli la fame, e l’uomo che si faceva chiamare Totò cominciò a raccontare i propri guai, così disse alla caldarrostaia di suo padre che l’aveva riconosciuto solo l’anno prima, di sua madre che voleva che smettesse di fare l’attore e si dedicasse a trovare una posizione più confacente nel mondo, magari diventando un contabile, e di sé stesso, che non aveva un soldo e che l’unica cosa che sentisse di voler fare, era far ridere la gente.
La caldarrostaia l’ascoltò, poi cominciò rigirare le castagne nella pentola fino a che non si fermò, ne prese una e gliela diede in mano.
“Sembra che le castagne abbiano tutte la stessa forma, ma non è affatto vero. Lo vedi quanto è bella grossa questa? Mangiala, mangiala pure”.
L’uomo che si faceva chiamare Totò mise la castagna in bocca.
“Hai sentito come è bella farinosa.” Disse la caldarrostaia. Nel frattempo, ne prese un’altra, un po’ più piccola, e gli diede anche quella.
“E’ quasi più gustosa di quell’altra. Vero?”
L’uomo che si faceva chiamare Totò annuì.
“Non ce n’è una uguale a quell’altra, e così è per le persone. C’è chi è nato per fare l’attore come te, chi per fare il contabile e chi per fare la caldarrostaia come me.”
La caldarrostaia continuò a rigirare le castagne con un mestolo.
“Lo sai che è da pochi minuti che ho messo delle altre castagne dentro questa pentola e non so più quali siano, e magari ce n’è qualcuna che è da quando ho iniziato che è qua, che continuo a rigirarla e che alla fine c’è il rischio che non se la prenda nessuno.”
Mentre nel cielo sopra Roma faceva capolino qualche stella lontana, a dire che quelle nubi che per tutto il giorno avevano imperversato sulla città all’indomani se ne sarebbero andate, l’uomo che si faceva chiamare Totò restò a guardare la caldarrostaia fino a che un pensiero non gli entrò in mente e rifletté che anche noi, come quelle castagne, cuociamo sulla nostra graticola sempre in attesa di qualcosa, fino che non arriva colei che non guarda in faccia a nessuno, né al ricco e né al povero, né all’uomo che ha talento e né a chi non lo ha e in quel momento ci viene dato appena il tempo di pensare a come abbiamo usato quello che ci è stato concesso.
Un sorriso schiarì lentamente il volto dell’uomo che si faceva chiamare Totò e mentre la caldarrostaia continuava a rigirare le castagne rimaste nella pentola, per la prima volta, quella sera, ebbe voglia di tornarsene a casa.

