Lucia Lo Bianco 2022
LAGUNANDO 2022 > selezionati 2022

Nata a Palermo, laureata in Lingue e Letterature Straniere e con un MA in Professional Development for Language Education, dal 1993 insegna inglese al liceo.
Poetessa, scrittrice, saggista e giornalista ha pubblicato sei sillogi di poesie “Le Ali ai Piedi”, 2013; “Il Faro”, 2015; “Il Silenzio del Tempo”, 2020; “Sono una barca” (2021); “Come una libellula” (2021); “E plana stanca sulla riva” (2022);
i racconti “Le donne lo dicono” (2021)
ed il romanzo “Dove gli angeli camminano di notte” (2022).
Co-Fondatrice di WikiPoesia, Accademica del Convivio e di Sicilia si è classificata ai primi posti in premi nazionali ed internazionali totalizzando circa 400 premi in Italia e all’estero.
Autrice già presente edizioni:
2021
2020
LEGGERE LAGUNE

POESIE
I Bambini e la guerra
Ricordi? Si parlava a bassa voce
noi bimbi senza sguardo sul domani,
voglia bruciante cresciuta sulle ossa
tra braci e vie corrose dai mortai.
Ed eran scoppi laceranti per orecchie
che avean udito le grida del terrore,
erano squarci spalancati verso il vuoto,
un buco nero d’universo indifferente.
Insieme varcavamo quel confine
che l’innocenza impediva di vedere;
all’improvviso un sibilo, una lama
ritagliava i colori alle pareti
e nuova forma, terribile bellezza,
sgorgava a sangue dal bianco del soffitto,
mentre un pennello incerto tra le dita
tracciava varchi e fosse negli abissi.
Come follia di torbido pittore,
tratti di un film riflesso sulle mura,
luce assassina, un fuoco sopra il cielo,
illuminava la notte come giorno.
E le parole annegavano il silenzio,
non c’era suono su carni martoriate.
Ma io rammento le fughe senza scarpe,
pelle tagliata da rocce incattivite;
né cancellare sapranno questi anni
l’odore acre di morte dentro casa.
Ricordi? Cantavano i fanciulli
ma il dolce miele nuotava senza meta.
Erano voci stonate e senza senso
prive di toni, perdute dentro il tempo.
Incanto di parole
E sale un grido sul muro generato
da questo tempo bugiardo di promesse,
da spessa coltre di morbidi pensieri
che ricamare sanno fronti fredde e stanche.
Ma dico basta a queste lacrime sospese
come gocce di rugiada persistenti,
mentre le pieghe sulla pelle martoriata
ancora avvertono una frusta sconosciuta.
Sai, le sferzate sono spilli alla parete
che come chiodi disegnano la croce
e non rimane che il flebile sospiro
di chi dell’aria perduto ha direzione.
E cala il velo della sera nell’attesa
mentre le stelle cominciano il bel canto
e mentre s’ode la voce della luna
come cristallo di fragile speranza.
Amica notte, sostieni il mio vagare
tra valli e monti con gli occhi immaginati
e non lasciare che scatole di pietra
possano spegnere il soffio sul mio viso.
Vedrai che il vento, compagno sulla terra
saprà dipingere la strada del destino
e la mia bocca vogliosa di magia
sarà soltanto un incanto di parole.
Ladri di pelle
(Alle donne ucraine, violate)
Sono giunti ancora quegli sguardi
tra le foglie accartocciate del giardino,
vesti nascoste senza forma né colore,
forme distorte su panni bianchi appesi.
Sono giunti nel cammino oscuro del destino
e riluceva il grigio acciaio delle armature
mentre sbucavano occhi dentro il buio
come dei topi annaspando sangue altrui.
Sono arrivati urlando fuoco sotto il cielo
a lacerare sipari scuri appena issati,
sotto una pioggia di lampi e di scintille
e odori acri di brandelli di cemento.
Han spalancato portoni sull’abisso
(le amiche stelle restavano a guardare),
e le parole erano scatole strappate
abbandonate a galleggiare sopra i fiumi.
Sono rimasti il tempo per scoprire
l’arma segreta che sputa la violenza,
senza lasciare uno spazio per volare
dentro la camera nascosta in fondo ai sogni.
Hanno lasciato bambole piegate,
scalfite a lungo come vecchie porcellane
e cenci unti, bagnati nel dolore,
un grigio perla di lacrime disperse.
Sono partiti: un carico di pelle
stipato a forza sui carri della morte,
come bottino di becera follia
a disegnare di vermiglio l’universo.
Notte di donna a Kabul
È giunta ancora tra le pieghe delle stelle
la notte buia e scura più di un manto
e soffia lieve il vento tra le cose
riposte piano in angoli di mondo.
Un’altra notte d’attesa sotto un cielo
che copre il freddo e il gelo della pelle,
un’altra veglia su cime d’orizzonte
distanti al tatto di mani vuote e stanche.
È giunta ancora la fine di quel giorno
un tempo atteso tra i colori delle vesti
e adesso restano anfratti chiusi a riccio
senza finestre aperte sul mattino.
Ed ora è qui e il sole più non brucia
sulle pesanti coltri del mio corpo,
né più la brezza o l’aria malandrina
spalanca porte aperte sull’abisso.
Ed io l’attendo seduta al davanzale
la lunga notte compagna dei sospiri,
senza riserve l’accolgo tra i capelli
che ho sciolto liberi, protetti dagli sguardi.
È giunta infine la falce della luna
che si rifrange tra i cocci degli specchi
e la sua luce sui fragili pensieri
sarà una voce urlata nel deserto.
Sono occhi scomparsi dentro il buio
(Per tutte le donne afghane)
Sono polvere gialla di deserto,
brucia la gola al vento.
Sono bocca arsa dal sole
e miele nel buio della notte.
Sono parole magiche di canto,
dolce suono al chiarore della luna.
Sono mamma che culla e che consola
e scaccio incubi di sonni tormentati.
Sono acqua e gocce di rugiada
per rinfrescare la pelle dal calore
e sono voce che grida nel silenzio,
dietro un velo increspato di follia.
Sono calma in attesa di tempesta
nel suo cammino ovattato sulla terra.
Sono una piccola scarpetta sulla sabbia
che quasi vola ma non fa rumore.
Sono occhi scomparsi dentro il buio
in angoli scomposti di paura,
sono un coperchio sul libero pensiero
rinchiuso a forza dietro finestre di terrore
e sono donna
in viaggio
verso un mare
immaginato
oltre orizzonti
in fondo al tempo.
ORTI DEI DOGI
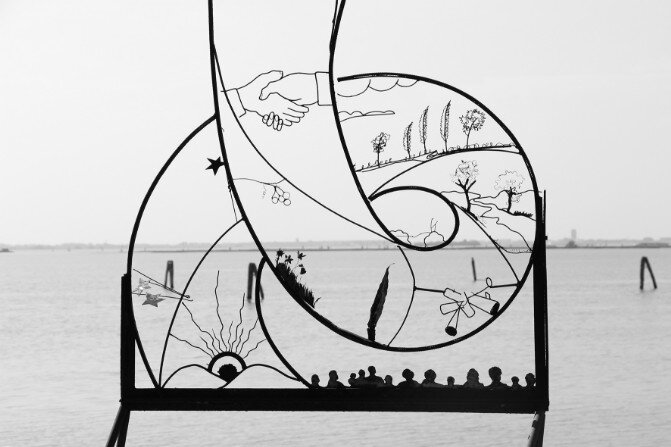
RACCONTI
IRINA NON GIOCA PIÚ ALLA GUERRA
Era rimasta così, arrotolata sotto la trave arrugginita dello scantinato impolverato del palazzo. Crollata la parete opposta, la deflagrazione aveva disegnato strani ghirigori sul muro un tempo bianco. Era rimasta così, accucciata sotto l’ala protettiva di ferro e di cemento, aggrappandosi a quell’ultimo e sicuro sostegno nel timore di venire trascinata nell’abisso. Troppi i morti intorno a lei per un gioco insensato di folle predominio sull’altro. Da quella posizione poteva contare solo i minuscoli segni lasciati sulla struttura che le stava sopra senza farla respirare, mentre la mente cercava di ricostruire quei pochi terribili attimi che l’avevano condotta lì, in quel buco ristretto di mondo senza futuro e senza storia.
A quarant’anni Irina aveva dovuto decidere in fretta se tornare in Ucraina e lottare per difendere la libertà del proprio paese o invece continuare a cullare la sua vita nella Milano post pandemia. I suoi genitori e i suoi amici erano rimasti lì, a Kiev, e adesso si rintanavano come topi nei sotterranei per sfuggire alle bombe. C’erano madri e bambini nei bunker, sotto bombardamenti imprevisti. C’era una vita oscillante tra normalità e follia tanto più illogica quanto più cieca e imprevedibile.
Ma lei non poteva continuare a rifugiarsi nelle braccia sicure di una società che l’aveva accolta dieci anni prima. Lei ingegnere informatico con una perfetta conoscenza di italiano e inglese aveva trovato facilmente lavoro in una società di telecomunicazioni e si era inserita nel tessuto sociale e culturale milanese al punto da dimenticare facilmente le proprie origini, se non fosse stato per quello sguardo triste e melanconico che emergeva a tratti dagli occhi verde chiaro e si rifletteva su una pelle chiara come la luce che l’aveva salutata al suo arrivo in Italia.
Il suo carattere forte e deciso, invece, l’aveva trascinata lì coinvolgendola in una cascata di eventi e situazioni che ora la tenevano stretta in una morsa senza uscita.
Una voce, un piccolo rumore, un suono fine e metallico alla sua sinistra la spinse a girarsi leggermente per quanto la posizione le impedisse di muoversi liberamente. Le sembrava di percepire una forma in un angolo distante dello scantinato, una massa di tessuto verde che luccicava a tratti sotto la fioca luce che penetrava attraverso le macerie. Si muoveva. Sì! Si muoveva a fatica tra un gemito e l’altro mentre mulinelli di polvere aleggiavano a mezz’aria come cerchi concentrici puntando verso il cielo.
“Chi sei?”, sentì la sua voce pronunciare quelle poche, semplici parole mentre la paura le stringeva le viscere e gocce di sudore freddo le scendevano sulle guance.
Dall’altra parte la misteriosa figura sembrava ignara della sua presenza e non aveva forse udito la sua richiesta.
“Chi sei tu? Ehi! Mi senti?”, urlò con quel poco fiato che le restava.
La massa scura si mosse di scatto. Stavolta l’aveva sentita. Nell’atmosfera opaca e indistinta che abitava in quel luogo due piccoli occhi la osservavano terrorizzati.
“Karina!”, seguì un lungo silenzio. “Mi chiamo Karina!”
L’accento non era sicuramente ucraino. Una donna russa lì, sotto le rovine di un bombardamento a Kiev. Cosa ci faceva lì? Sapeva di convogli di soldati russi inviati ad occupare la sua terra, quell’Ucraina che era riuscita anni prima a liberarsi dal dominio del gigante ingombrante che aveva imposto tutto, schiacciando il loro idioma oltre che le loro persone. Dall’alto il Presidente Putin aveva da tempo preparato quell’offensiva che mirava ad annientare ogni loro difesa, bloccando rifornimenti di luce, gas e cibo.
“Aiutami, ti prego!” Parlava a fatica. Doveva essere ferita. “Ho una gamba bloccata sotto un blocco.”
“Non so se riesco ad uscire da qui.” Seguirono attimi di spaventoso silenzio. “Ci provo.”
Irina cominciò lentamente a spostarsi trascinandosi e rotolandosi nella polvere. Era sempre stata lesta ed agile e da ragazza, mentre frequentava l’Università proprio lì, nella capitale, aveva preso parte ai campionati nazionali d’atletica specializzandosi e ottenendo dei risultati significativi nel salto in lungo.
Le sue gambe si stendevano e si piegavano in movimenti ritmici, quasi stesse eseguendo esercizi di ginnastica programmati. I piedi, intrappolati nei duri scarponi che alla fine aveva racimolato, non l’aiutavano più di tanto e non riusciva a mantenere la presa con un terreno irregolare e stracolmo di macerie e calcinacci. Intanto sbirciava la figura che poco distante le lanciava occhiate di furtivo terrore non riuscendo a identificarla come un’amica, ma trovandosi al contempo nell’impossibilità di decidere altrimenti.
Quando fu a pochi passi da Karina decise che si sarebbe fermata un momento per calmare il fiatone che le impediva di procedere come avrebbe voluto. Una forte presa al braccio la fece sussultare. Non si era accorta che Karina era riuscita a stendere il braccio e a raggiungerla stringendola forte.
“Lasciami”, per quanto si sforzasse non riusciva a liberarsi da quella mano che le avvinghiava il braccio. “Cosa vuoi da me?”
“Devi aiutarmi!” Due occhi lucidi e febbricitanti sembravano entrarle dentro senza tregua. Irina se ne stava come incantata a fissare quel volto un tempo forse bellissimo. Doveva avere circa cinquant’anni ma come capire l’età di un essere umano travolto dalla barbarie della guerra?
“Cosa posso fare per te?”, non capiva proprio perché si trovasse sul punto di aiutare chi aveva distrutto il suo paese.
“Sono venuta a cercare mio figlio. E’ stato mandato qui, non è colpa sua. Se non avesse obbedito sarebbe stato messo in carcere. Il mio Sasha”, Irina vide l’altra mano di Karina infilarsi sotto il muro e tirar fuori un minuscolo pezzo di carta. “Sono stata colpita da una granata, non ci vedo più. Non credo mi resti molto”, un luccichio di lacrime sul suo viso creò strani bagliori in quel contesto irreale e diabolico di morte. “Devi darlo al mio Sasha. Ho scritto due parole per lui.”
“Ma io… come posso….”
“DEVI DARGLIELO!” Era impossibile sottrarsi a quella voce spezzata e metallica. Era un suono simile ai sibili di mortai prima che scoppiassero. Era un ritmico traballare di rumore come i fucili che sparavano dappertutto sopra di loro. “Leggila!” Irina riuscì a stendersi quel tanto che il corpo stanco e dolorante le permettesse e alla fine una carta sudata e appallottolata trovò posto nel suo pugno. Si trattava di una letterina scritta in russo, la lingua che tutti quelli della sua generazione erano stati obbligati a studiare a scuola.
“Sasha, amore mio,
una mamma vorrebbe dire tante cose a un figlio costretto a giocare alla guerra. Ti amo con tutta me stessa e mai avrei desiderato separarmi da te in questo modo, senza un abbraccio. Sognavo di seguirti nei tuoi anni e di vederti crescere ma l’innocenza è andata via con le armi nel tuo zaino e forze più grandi dell’amore di una mamma occupano ogni fibra del tuo giovane corpo senza rimedio. Lo sai? Anche tuo padre era un soldato e come te pedina di una lotta tra confini inesistenti. Come te tuo padre è andato via un giorno trascinato dalla follia di un solo uomo e dalla vuota retorica di un eroismo che non esiste, becera ideologia a vantaggio di pochi. Come te tuo padre ha lasciato me, una donna, a ricomporre i pezzi del suo mondo distrutto. In fondo tocca sempre alle donne, poi, far tutto.”
La tua mamma
Irina quasi non si accorse degli occhi che le si erano inumiditi durante la lettura ma alzando lo sguardo percepì l’assenza di Karina. Se n’era andata in silenzio lasciando una piccola massa verde scuro sotto la trave grigio perla che le tratteneva il corpo. Quella piccola massa verde scuro ora non respirava più e la stretta sul suo braccio si era allentata senza che lei quasi se ne accorgesse. Era troppo tardi ormai per farle delle domande.
Non le restava che stringere quella letterina tra le dita programmando il da farsi. Sarebbe riuscita a incontrare Sasha? E come? Non ne conosceva neanche il cognome. Avrebbe trovato tanti giovani soldati, tanti Sasha. Forse avrebbero gradito ugualmente quella lettera. Tutti quei poveri Cristi spediti a combattere senza capire bene cosa e chi! Chiunque si sarebbe identificato con quelle poche parole colme di senso in una realtà che di senso aveva ben poco. Aveva sentito che un giovane soldato russo era stato catturato dagli ucraini l’altro giorno. Si era messo a piangere. Era terrorizzato al pensiero che mamma non avesse sue notizie. Lo avevano tranquillizzato consentendogli di chiamare casa per dire a sua madre che lui era ok, che stava bene e che lei non doveva preoccuparsi.
Era così da sempre. Toccava sempre alle donne raccogliere i cocci di uno specchio infranto cercando un collante inesistente per ricostruire una realtà che sarebbe rimasta inevitabilmente scheggiata. Toccava alle donne subire le conseguenze di decisioni non prese e sofferenze non volute. Si era sempre chiesta perché, dopo tutto, non toccasse mai alle donne prenderle quelle decisioni e che il mondo sarebbe certamente stato diverso se a reggerlo fosse stato l’universo femminile.
Alla luce fioca del giorno appena spuntato il cielo copriva solo in parte i gesti furtivi di chi scappava qua e là nella paura di un attacco dall’alto. Oppure si temevano i vicoli nascosti, angoli bui senza luce nei primi bagliori del mattino che avrebbero potuto ospitare soldati nemici pronti a sparare o ad uccidere con bombe improvvisate. Spesso l’attacco giungeva da un tuo pari, un amico purtroppo nemico in attesa di un colpo sicuro e un bottino di guerra da mostrare come un roseo trofeo.
Lei, Irina, si muoveva su muscoli stanchi, assopiti da giorni di stasi e le parole erano rimaste bloccate in una gola arsa, senz’acqua a cancellare la polvere che la soffocava e la faceva tossire.
Fu proprio un colpo di tosse a tradirla. Non era riuscita a trattenerlo. Un soldato saltò fuori come una talpa da una buca imprevista e sparò alla cieca, senza vederla veramente. Un azzurro senza nuvole si palesò improvvisamente sulla sua stanca, esile forma di donna salutando i suoi occhi per sempre mentre la sua pelle restava sospesa tra terra e cielo e il vento scompigliava l’oro dei capelli sotto il sole.
Tra le dita un foglietto sgualcito, con poche parole scritte, additava al cielo lontano.

