Sandro Cisolla
Lagunando 2025 > AUTORI 2025 > Poesia 2025

Note:
classe 1984, è un copywriter, ghost writer e scrittore. Alterna la sua vita tra il lavoro in ambito pubblicitario e digitale, e la scrittura di romanzi, racconti e poesie. Sin da piccolo mostra una particolare propensione per il mondo della parola scritta, per lui un filo continuo che si estende “da cuore a cuore”.
All’attivo ha due pubblicazioni ufficiali: Radici (“romanzo con ricette” edito per Rizzoli nel 2018) e il Grande Sesamo (edito per la Torre dei Venti nel 2021).
Il suo amore per la scrittura può essere riassunto nella seguente frase: “Le parole formano il pensiero. Per questo, scrivere è sinonimo di responsabilità”.
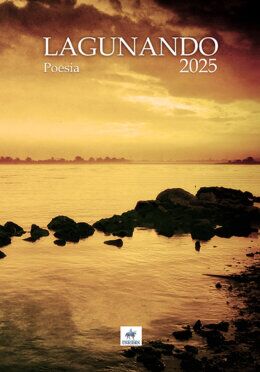

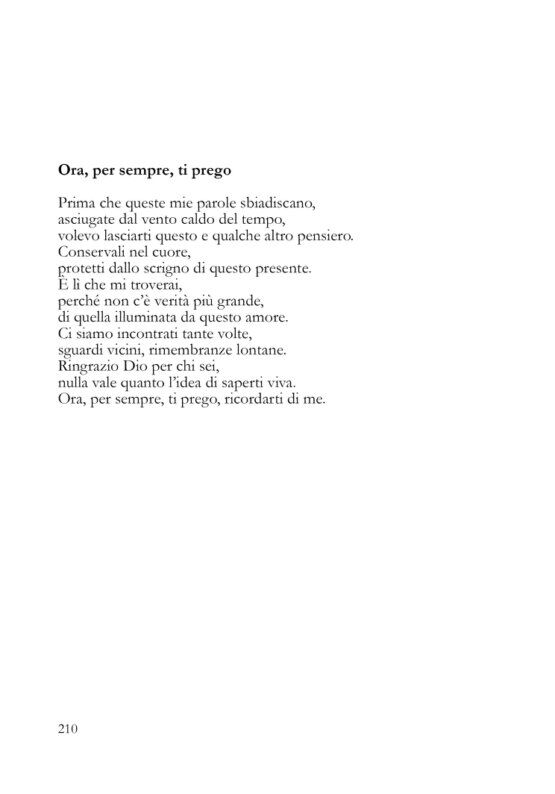

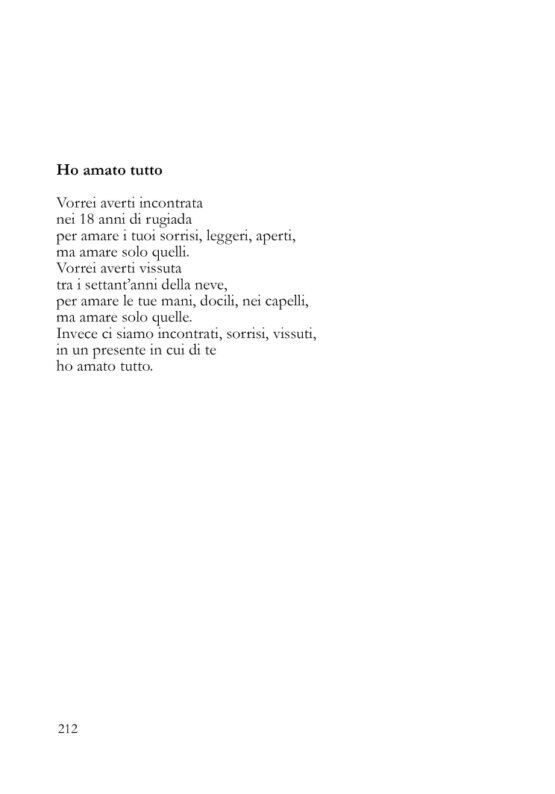
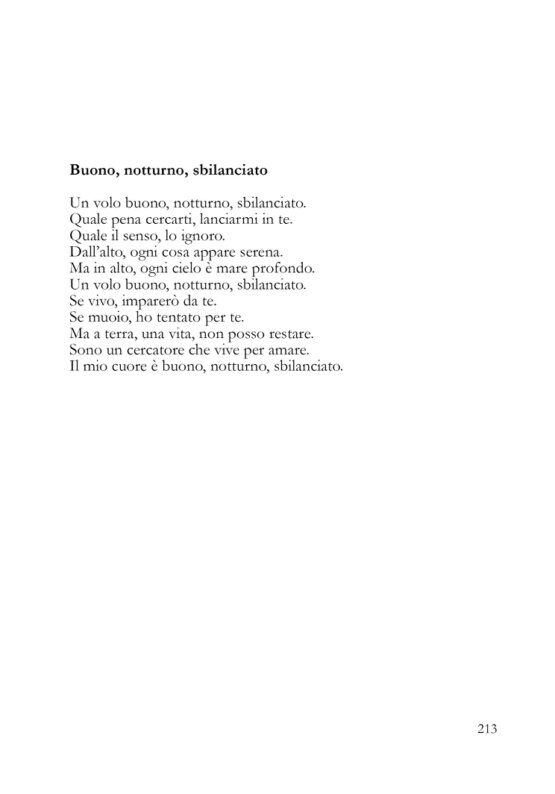
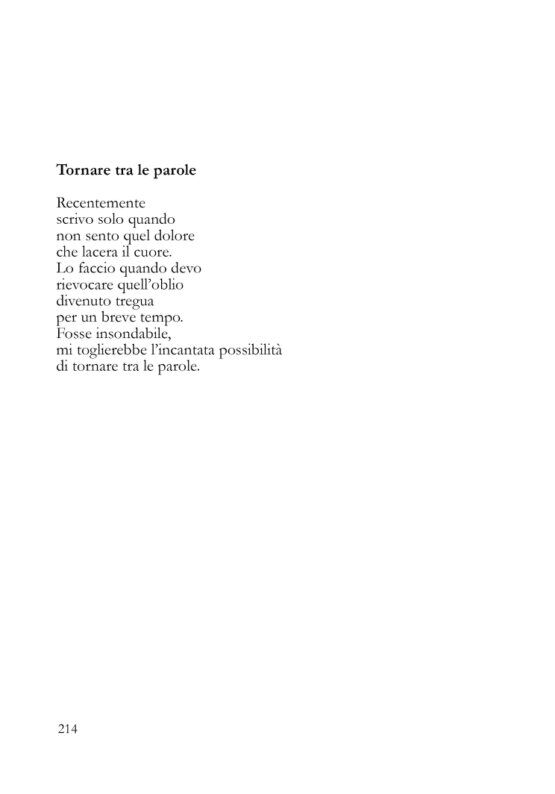


SECONDO CLASSIFICATO RACCONTI
L’acciacco
Iniziai a realizzare davvero che mi trovavo in una nuova casa diversi mesi dopo che vi avevo preso possesso. La fine del mio matrimonio era giunta come una tempesta violenta, sbattendo la mia debole scialuppa contro gli scogli dell’abbandono, e io mi trovai improvvisamente da solo tra quattro pareti che sentivo non appartenermi più. Nel giro di pochi mesi dovetti quindi darmi da fare per dare una nuova forma a quel cumulo di umida argilla che era la mia vita. Ebbi la doppia fortuna di riuscire a trovare degli acquirenti per la vecchia casa in cui io e mia moglie avevamo vissuto per quattro anni - me ne occupai da solo, perché lei era letteralmente scomparsa nel nulla - e nello stesso momento di imbattermi in un piccolo appartamento dietro la ferrovia. Era mal messo poverino, con quella muffa che si arrampicava sulle pareti e le sue stanze vuote che parevano aver numerose storie senza lieto fine da raccontare. Tuttavia, riconobbi quello stato di fatiscenza come familiare e fu questo forse a guidarmi al suo acquisto. Ricordo poco dei due mesi che occuparono il restauro di quel nuovo nido. La confusione e il dolore invadevano come scarafaggi ogni secondo delle mie giornate e l’unica cosa che mi venne di fare per difendermi da quella presenza infestante fu calarmi nei panni di un automa. Eseguivo, come un soldato. Mi recavo nei negozi per scegliere i mobili, coordinavo gli operai, controllavo che demolissero e costruissero dov’era necessario, analizzavo preventivi e inviavo bonifici. Ero un essere perfettamente inesistente. Si dice che il periodo concomitante all’acquisto e al restauro di casa propria sia indimenticabile, l’inizio di una nuova vita che rimane incastonato nello scrigno dei ricordi per sempre. Fu così anche per me, quando ciò avvenne con la donna che amavo. Ma quattro anni dopo, quando mi trovai a dover rivivere quel momento in ben altre condizioni, una fitta nebbia invase ogni cosa. Anzi, forse fui proprio io a generarla, sbuffando poderose nuvole di fumo bianco sui contorni di un presente che riconoscevo ancora come inaccettabile. L’unico vago ricordo che ho di quel periodo è legato alla mattina successiva alla mia prima notte nel nuovo appartamento. Era metà settembre, e fui svegliato dall’ultimo sole di un’estate che - già lo sentivo - presto si sarebbe trasformata in un malinconico canto autunnale. I suoi raggi filtravano decisi dai vetri della camera, nonostante lo spesso strato di polvere che ne ricopriva la superficie e che non avevo ancora avuto anima di pulire, conclusi i lavori di restauro. Mi fiondai in quella che sarebbe dovuta essere la mia cucina - l’avrebbero montata solo due settimane dopo il mio ingresso, costringendomi a mangiare pizze in cartone e cibo cinese da asporto come un moderno eremita metropolitano - accesi il bollitore e mi preparai un tè. Presi una mela e la sgranocchiai in terrazzino sorseggiando la mia bevanda calda, a occhi chiusi, lasciando che la luce del mattino violentasse la mia pelle di lucertola. Fu in quel momento che lo vidi per la prima volta. Aprii gli occhi nell’esatto istante in cui la sua voce festosa dall’accento meridionale scosse il mio torpore. «Alessandro! Alessandro! Benvenuto!» Ripeté il mio nome - sbagliandolo - per due volte, e io non potei fare altro se non voltarmi nella sua direzione. Dal balcone di fronte al mio terrazzino, a circa una trentina di metri in linea d’aria, stava un uomo calvo e sorridente. Ondeggiava la mano a destra e sinistra, quasi stesse salutando dal porto una nave in partenza, e fermò quegli ampi movimenti solo quando io risposi. Non gli chiesi né chi fosse né come (non) sapesse il mio nome, mi limitai semplicemente a ringraziare con un sorriso inebetito. «Mi chiamo Mario!» mi disse sempre con quel tono da primo dell’anno, poi mi chiese che programmi avessi per la mattinata. Non era curioso, piuttosto incuriosito. «Penso lavorerò un po’. Mi chiamo Sandro, comunque» gli risposi poggiando la mano sulla fronte per osservarlo meglio in controluce, e lui annuì un paio di volte, sorridendo. «Bene, bene» rispose «lavorare va bene.» Poi arretrò di qualche centimetro e si riportò dentro, all’ombra di casa sua. Fece un altro cenno con la mano e con un tono più pacato mi salutò così: «Bravo Alessandro, a presto e benvenuto». Io sollevai la mano stancamente e mi limitai a trasformare la mia mela in un torsolo striminzito, ad occhi chiusi. Al momento non realizzai l’importanza di quell’incontro né del suo protagonista, e non lo feci nemmeno il giorno dopo quando lo vidi uscire più o meno alla stessa ora, steso su una barella. Mi affacciai di colpo al parapetto del terrazzino e in quell’istante lui mi rivolse uno sguardo, certamente meno allegro della mattina precedente. «Alessandro, Alessandro» disse «oggi piove, hai visto?» Aveva iniziato a piovere in effetti, e io non me ne ero ancora accorto. Sollevò la mano a malapena, con un gesto stanco come il suono della sua voce, poi scomparve dentro l’ambulanza.
Non lo vidi per diversi mesi, e il ricordo di quell’incontro ingiallì in poco tempo come le pagine di un libro dimenticato in giornate troppo distratte. Lavoravo, vedevo qualche raro amico e soprattutto cercavo di prendere confidenza con una vita nuova e sicuramente meno felice di un tempo. Ma, sopra ogni cosa, non riuscivo ancora a percepirmi “a casa”. Rifiutavo la forma della solitudine.
Tutto iniziò davvero a cambiare in primavera, dopo un lungo e buio inverno. Credo fosse la seconda metà di maggio. Era sera e stavo stemperando l’affanno della giornata guardando alla televisione Dracula di Bram Stoker (tanto per ricordare a me stesso che l’amore è un affare di una certa complessità). Me ne stavo steso sul divano, indeciso se lasciarmi andare a un sonno anticipato - erano circa le 21.30 - o continuare a sforzarmi di tenere gli occhi aperti. Le finestre erano spalancate, perché l’estate quell’anno pareva decisa a spingere sull’acceleratore, ma nemmeno sforzandomi avrei potuto immaginare ciò che accadde di lì a pochi secondi. Proprio nell’esatto istante in cui il vampiro affondò i canini sul collo di Mina, un pipistrello grande quanto due mani si fiondò all’interno del salotto. Ebbi giusto il tempo di portarmi ritto in piedi, percepire inorridito lo spostamento d’aria causato da quelle ali di pece, per poi osservare la creatura prendere la strada del corridoio e spostarsi verso le camere, al buio. Avrei potuto inseguirlo, fare qualcosa per sincerarmi che ritrovasse la strada per la notte, ma tutto ciò che mi venne di fare fu fiondarmi in terrazzino a fumare.
«Alessandro, Alessandro! Che fai? Che fai?» Quella voce mi tornò immediatamente familiare.
Mi voltai e potei scorgere, illuminata dalla luce alle sue spalle, la silhouette di Mario, alla finestra. Sembrava diverso, la sua postura era più curva e dimessa, e nonostante il buio della notte non mi permettesse di esserne sicuro, mi parve indossare una vestaglia. L’unico dettaglio che notai senza margine di dubbio fu la posizione della sua mano, accartocciata su se stessa, non più stesa in segno di saluto. «Mi rifugio in terrazzino» risposi «mi è appena entrato un pipistrello in casa.» «Oh beh, questa è bella.» Rispose lui, con voce lievemente soffocata da una risata che si trasformò presto in un colpo di tosse. «Hai spento le luci? Devi spegnere le luci e quello se ne va» proseguì poi. Gli dissi che le luci delle camere erano spente e che si era diretto proprio lì, ma che non avevo il coraggio di andare a controllare. «Allora vedrai che se n’è andato. Chissà com’era spaventato, tutto solo a casa di estranei.» Poi mi salutò con un morbido “buonanotte”, chiuse la finestra e dopo qualche istante vidi spegnersi la luce dietro le tende. Nei giorni seguenti, credo per tutta l’estate, ebbi l’opportunità di comunicare con Mario quasi ogni giorno, dal mio terrazzino alla sua finestra. Mi raccontò che era stato un professore di educazione tecnica alle scuole medie, che si era trasferito dalla Puglia al Nord quasi quarant’anni fa e che non aveva mai avuto dei figli, perché gli era mancata una moglie con cui farli. Mi disse anche che era un po’ rattristato per il fatto che quell’estate non sarebbe potuto andare a trovare le sue sorelle a Bari a causa di quell’acciacco - usò proprio questo termine - che gli era piovuto addosso come un temporale. “L’acciacco” era stato un ictus che l’aveva obbligato su un letto per quattro mesi prima di riprendere, contro ogni previsione, a parlare e stare in piedi con le sue gambe. «Le persone peggiori sono le facce de du novembre, quelle che non credono nei miracoli» mi disse un giorno «perché consumano la batteria della speranza.» Sosteneva che oltre il cielo, probabilmente nell’Universo, ci fosse una grande riserva invisibile da cui tutti “i sorridenti” - chiamava così le persone diverse dalle facce da due novembre - potevano attingere la loro personale dose di speranza da utilizzare nel momento del bisogno. Quelle che non credevano nei miracoli, invece, secondo lui facevano il contrario: rubavano la speranza senza usarla e la sprecavano, disperdendola nel nulla come fosse munnezza. L’ultima cosa che mi disse fu «tu sei un sorridente Sandro! Sei un sorridente!» Mi chiamò col mio nome.
Mi trovavo fuori città quando Mario morì, il due di novembre. Un suo vicino mi informò, qualche giorno dopo, che aveva avuto un infarto improvviso e che il suo corpo era stato trasportato in Puglia per essere sepolto nella sua terra. Non sono mai riuscito a stringere la mano a Mario, ma sono convinto che io e lui ci siamo incontrati diverse volte a metà di quel ponte invisibile che separava il mio terrazzino dalla sua finestra. L’avevamo costruito coi mattoni della speranza che entrambi custodivamo gelosamente e che, a dire il vero, forse lui possedeva in quantità maggiore rispetto a me. Su quel ponte è stato Mario a stringere la mia mano, per traghettarmi giorno dopo giorno e senza che me ne accorgessi in un nuovo luogo che oggi chiamo casa. Credo che lui lo sapesse ciò che stava facendo, e forse lo sa tutt’ora, mentre vaga nell’universo con le batterie cariche di speranza.
