Silvano Visintin
Lagunando 2025 > AUTORI 2025 > Poesia 2025

Note:
Nato a Venezia nel 1949. Maturità classica. Laurea in Lettere.
Docente materie letterarie negli istituti superiori di Venezia dal 1977 al 2013.
Polisportivo: alpinista e marinaio.
È stato per vent’anni skipper in Mediterraneo e lavorando nelle navi mercantili ha effettuato per due volte il giro del mondo.
Ultimamente ha pubblicato il suo ultimo libro: “Venezia- soggetti smarriti” (Editoriale Unicorn Edizioni) presente al Salone del libro di Torino 2025.
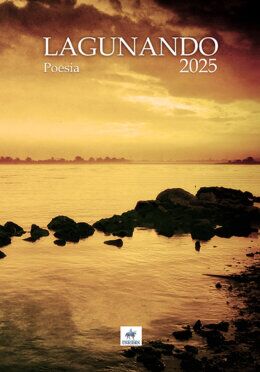
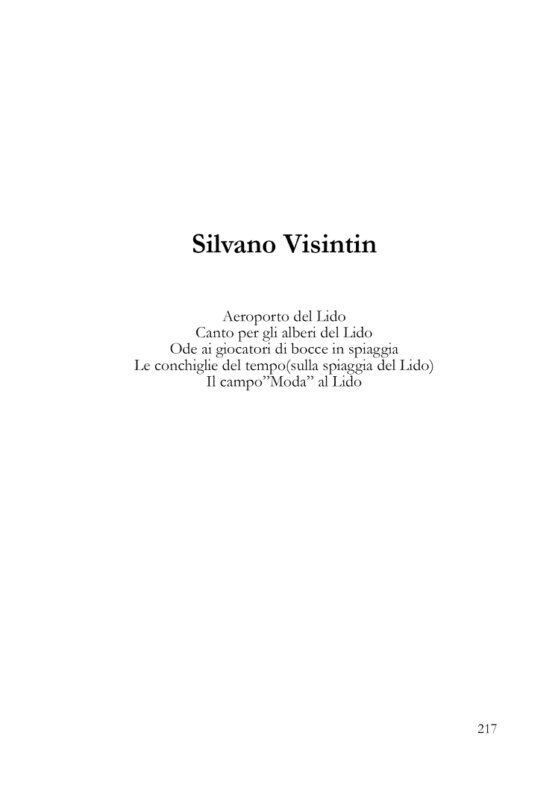


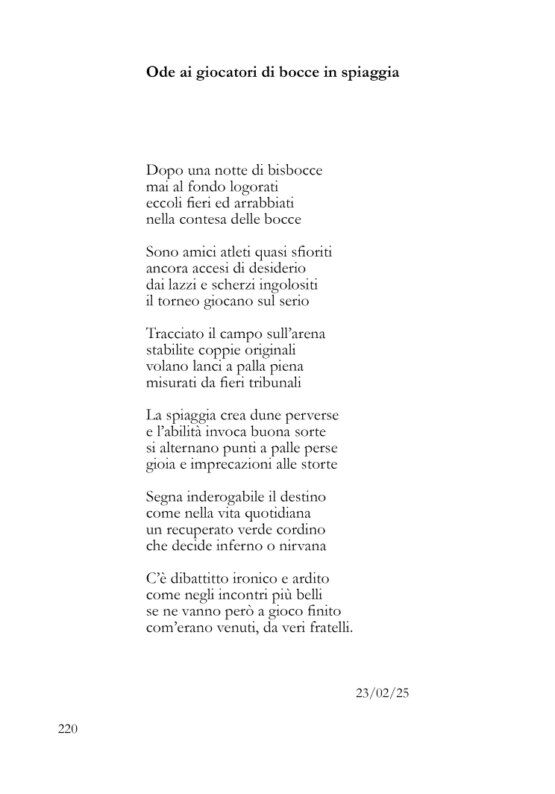
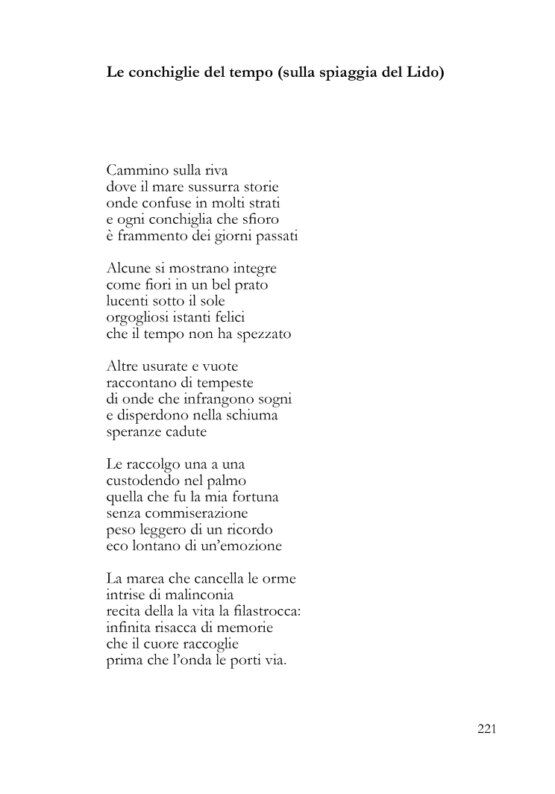
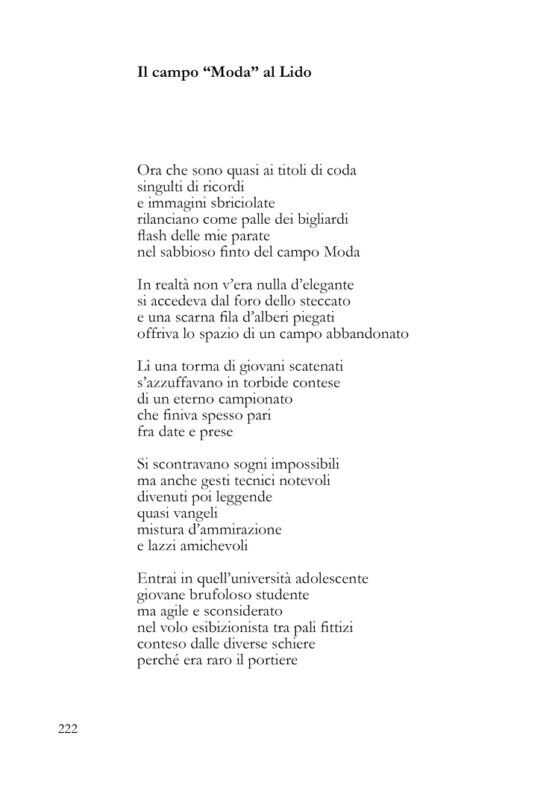
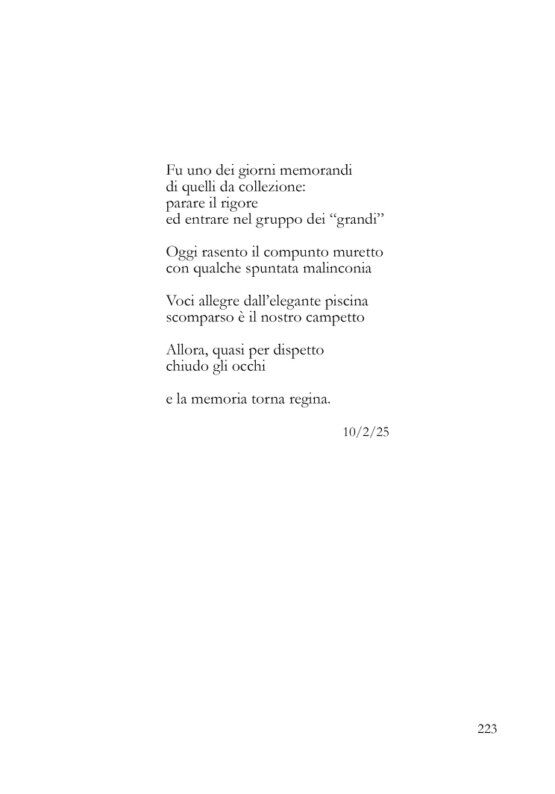

La rinuncia
Il vento rinforzava. La neve fine, ghiacciata, con piccoli chicchi, sbatteva violenta sul nylon della giacca alimentando il concerto disperato. La nebbia continuava a salire lungo la parete e tutto avvolgeva. Quando sembrava schiarire, era subito sostituita dal turbine della nevicata che a volte si faceva pasciuta, quasi allegra nei vortici dei fiocchi ora più grossi.
Come poteva essersi messo in quella cazzo di situazione? Sospeso alla corda ormai incastrata dal tessuto sopra la spalla, dentro al moschettone che sosteneva l’imbragatura ad anello del cordino per la doppia. Senza un Prusik di sicurezza. Bloccato sul vuoto. Un salto diretto di cui non poteva scorgere la dimensione. Una piccola sporgenza, un tetto e la nebbia ostruivano la vista. Un volo comunque di certo mortale. Avvicinarsi alla parete era impossibile. Distante almeno un paio di metri e in più come aggrapparsi, dopo un ipotetico pendolo, abbandonando la posizione chiusa delle mani sulla corda, unica certezza di freno oltre all’incastro del tessuto che aveva bloccato il libero scorrimento?
La tecnica rudimentale di discesa a corda doppia che era apparsa così semplice e divertente, rivelava ora tutti i suoi rischi. L’anello di cordino su cui si infilavano le gambe, veniva agganciato davanti ad un moschettone su cui poi passava la corda doppia. La mano destra avanti all’anello di ferro, la sinistra di fianco a sorreggere la corda che passava sopra la spalla e dietro la schiena. L’attrito e l’apertura o chiusura del braccio sinistro verso il centro costituivano il freno. Si procedeva un po’ piegati di lato per controllare in basso e, spingendo coi piedi sulla parete, ci si staccava dalla roccia. Salti magnifici, un po’ brucianti sulle mani, ma entusiasmanti e quasi deliranti di onnipotenza. Un volo controllato che appariva perfino troppo facile dopo le difficoltà aspre della salita. In più c’era l’entusiasmo della vittoria appena conquistata e, nel suo caso, il ritorno verso la sicurezza dopo l’acerbo conflitto con il vortice del vuoto.
“Ohee… Silvanooo… Fa presto che dopo no trovemo più i ciodi….Fa presto che la neve copre tutto…Prestoo!!” Da dietro lo spuntone di roccia la voce di Andrea, capocordata sceso per primo a cercare i chiodi cementati per la doppia, giungeva attutita dal vento. La nebbia la riportava in alto, ma la trasformava, la trasfigurava quasi non fosse lo stesso di prima. Non si vedevano e lui non poteva capire quanto la situazione fosse complicata.
Stavano scendendo dalla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo. Era settembre ormai inoltrato. Sfruttavano gli ultimi giorni di vacanza prima della ripresa delle lezioni al liceo. Festeggiavano la promozione dopo gli esami di riparazione. La roccia era una passione convergente dei due compagni di banco. Andrea era il più esperto ed anche il più bravo. Laureato dal suo secondo corso di roccia, e favorito dalla bella casa dei suoi, a Tai di Cadore.
“Vieni ospite da me una settimana e facciamo un bel po’ di vie” L’offerta allettante aveva uno scambio paritario: la NSU Prinz del padre di Silvano, felicemente patentato ed ora in grado di contrattare il successo scolastico col prestito del nuovo veicolo. Con la “vasca da bagno” grigio tortora che però non temeva la salita, avrebbero potuto spostarsi rapidamente nei dintorni dove le Dolomiti offrivano il meglio di sé. Silvano era emozionato. Il suo amore per l’arrampicata, nato dall’abilità di salita degli alberi di ciliegie, e poi degli abeti, dei pini, querce e di tutto ciò che fosse verticale durante i soggiorni estivi a Tonezza del Cimone, gli era valsa l’ammirazione dei locali e l’appellativo di “sghirato” “scoiattolo” di cui da bimbo andava fiero. Ma mancava la roccia nell’altopiano verde di pascoli e boschi. Spesso, dopo qualche temporale, puntava i vecchi binocoli della guerra verso l’imbiancato monte Pasubio che si scorgeva lontano nella fenditura della vallata. Immaginava le grandi montagne imponenti, quelle che aveva visto solo nei film. La conquista del Cervino, gli italiani sul K2. Grande fu dunque la gioia di scoprire che il suo nuovo compagno di banco era un rocciatore e presto questo divenne l’argomento principe delle conversazioni. Perfino le fughe di sopravvivenza dalla scuola, nelle giornate delle verifiche di primavera, finivano per diventare palestre di arrampicata. I muretti di mattoni sbucciati, lungo le rive delle Zattere, scaldati dal sole avevano segnato fino a sangue le dita delle mani nel tentativo di passaggi arditi di traversata. Erano arrivati perfino a noleggiare una barca per raggiungere l’isola abbandonata della laguna. Lì c’era un vecchio edificio diroccato, alto tre piani. Dalla terrazza che fungeva da tetto avevano esercitato la tecnica della discesa a doppia sfruttando la vecchia corda di canapa dello zio di Andrea, maestro e mito della loro passione.
“Silvanooo… Svegliaa… Non posso più star fermo… Fa presto… Tra un po’ sarà buio… presto… Dai movite!” Questa volta la voce di Andrea fu imperativa ed anche spaventata. Silvano colse subito lo sbalzo del tono, scremando gli improperi tipici del carattere a volte bizzoso del compagno. Ora c’era davvero una forte preoccupazione che aveva intaccato l’esibita sicurezza delle volte precedenti. Come quando Silvano si era fermato sul passaggio di quarto, durante la sua prima vera arrampicata in parete. Erano sulla Torre Lisi, alle cinque Torri, una via di terzo e quarto. Silvano l’aveva affrontata molto agilmente, stupito quasi dalla sua abilità nel macinare la gradazione che sulla carta incuteva timore. Solo al passaggio più duro, dove tutto diveniva più verticale e gli appigli, benché sempre solidi, richiedevano dita artigliate e punte degli scarponi bene in appoggio, solo lì aveva avuto un attimo di esitazione, non di paura. Forse voleva solo rendersi meglio conto di come si stesse dentro al film che tante volte si era immaginato. Si era girato verso il basso a cogliere il vuoto della parete e poi verso l’alto che appariva schiettamente verticale. Gli scarponi di Andrea sporgevano un po’ dalla nicchia della sosta, mentre ben assicurato si sporgeva per guardare il compagno in salita e le mani lavoravano al recupero della corda. “Sta fermo che ti faccio una foto!” Gli aveva urlato con una punta di maliziosa crudeltà tipica dei compagni di classe. Ma in quel frangente, benché un po’ rischiosa nella manovra di estrazione della fotocamera, la sicurezza del capocordata gli era parsa confortante. Così evidente fu la carica positiva che riuscì ad esprimere un convinto sorriso all’obiettivo (una foto molte volte esibita alla ragazza dell’epoca). Un attimo dopo, quasi a confermare una padronanza parallela, aveva superato il passaggio ed era a fianco del compagno.
Ma ora la situazione era diversa. Si trovavano ancora a metà parete e, per quanto ingannevole fosse la scenografia della nebbiosa nevicata, era evidente che la luce stava calando. Dopo le doppie che dovevano ancora completare, la bibbia del Berti annunciava un sentiero tra “sfasciumi” prima di raggiungere la base della parete. Detta così parrebbe una pacchia, salvo il fatto che il sentiero si trova solo per evidenza visiva, non è segnalato. Al suo fianco si sviluppano graziosi salti verticali e gli “sfasciumi” sono notoriamente composti da tanti piccoli e grandi sassi su fondo rigido che, nella discesa rapida sulla diagonale della pendenza, fungono da birichini trampolini per la caduta.
La neve e la nebbia avrebbero reso tutto più divertente. Se poi si aggiungeva il buio, la frittata era fatta. Questo dava alla voce preoccupata di Andrea un’adeguata giustificazione.
Ripensandoci tutto aveva girato un po’ storto quel giorno. A partire dalle previsioni del tempo (Non certo precise come quelle di oggi, si era nel 1967) che promettevano ancora qualche giorno di variabilità senza fenomeni temporaleschi. Erano state smentite rapidamente da una continua alternanza di nubi che avevano instillato una certa ansia, solo in parte temperata dalla voce del gestore del rifugio Auronzo, che prometteva tranquillità almeno fino a sera. Poi il ritardo con cui erano partiti da Tai di Cadore. La recita alpinistica non intaccava l’esuberanza dell’età. Si tirava fino a tardi quasi senza volerlo. E in quella soffitta, tra l’odore del legno, i lazzi e le risate si prolungavano quasi fino all’esaurimento delle forze. La strada in auto poi si era rivelata più lunga e tortuosa del previsto. Durante l’avvicinamento all’attacco della via passarono vicino alla chiesetta, sul sentiero che porta alla parete. “E’ qui che portano i corpi – aveva dichiarato Andrea – dopo che li hanno raccolti nei sacchi” E la mente corse rapida alla tragedia di qualche giorno prima. Una sferzata di realismo agli arditi sogni di gloria. Su quelle pareti ci si poteva lasciare la pelle.
Infine la parete. Andrea aveva detto che non era particolarmente difficile, ma un po’ lunga. Silvano si fidava senza riserve, ma giunto all’attacco della roccia verticale gli parve che l’appellativo di Piccola fosse del tutto relativo.
Fino ad allora, aveva camminato quasi a testa china per seguire il passo di Andrea. Lui era più alto, aveva la gamba più lunga, era meglio acclimatato, viveva da mesi in montagna. Soprattutto era un po’ incazzato. S’era fatto serio, capiva che erano in ritardo rispetto al progetto, ma era cosciente anche della sua responsabilità. Una complice colpa comune di cui non avevano fatto cenno. Solo un vago “dovremo far presto” quando avevano parcheggiato la macchina e stavano riordinando i materiali nello zaino. Poi più nulla. Ma Silvano si era accorto che il passo del compagno andava progressivamente accelerando ogni volta che aveva consultato l’orologio. Per orgoglio o per senso di colpa non aveva detto nulla. Non era forse stato lui ad insistere nella notte per avere di nuovo i racconti della vecchia baita ai piedi dell’Antelao? Quelle storie già sentite, ma che come i bimbi non si stancava mai di ascoltare. Insomma se avevano fatto tardi anche lui era responsabile, dunque pedalare. Aveva trovato modo di accentuare la concentrazione imitando i gesti del compagno. Cercava di mettere i piedi sullo stesso sasso, di tenere il ritmo di quella danza di contrappesi cantando mentalmente “vecchio scarpone”. Fingeva di essere in discesa e di non sentire le bretelle dello zaino che volevano tornare a casa. Neppure il sudore che cominciava a solleticare la schiena lo distraeva dall’impegno. Ma la falcata era decisamente diversa e spesso doveva compensare con qualche passo intermedio. Tuttavia il percorso del sentiero impervio, che diveniva sempre più ripido, si disegnava nitido suggerendo gli appoggi. Uno, due – uno, due – e il brunito degli scalini suggeriva che non erano stati i soli a scegliere quella successione. Una sorta di saggezza collettiva che peraltro spesso si manifestava analoga, se non ancora più precisa, nei passaggi sulla roccia, talvolta lucidati dai tocchi di centinaia di mani. La testa era dunque rimasta per gran tempo china a scoprire le tracce come Pollicino. Solo qualche alzata per prendere fiato e osservare la valle con la strada che progressivamente si allontanava. In avanti guardava poco, perché temeva di perdere coraggio scoprendo che erano ancora distanti dalla meta. Aveva deciso di farsi sorprendere dall’arrivo. Pensava che mancava ancora poco. Fingeva di esserne certo, perché cominciava a sbuffare e sentiva ora il calore crescente sulla schiena bagnata oppressa dallo zaino di pietra.
“Ci siamo!” affermò perentorio Andrea, assumendo la posa tipica dell’alpino. Una gamba tesa a valle e l’altra flessa verso la montagna, mentre si spogliava dallo zaino per cominciare a trarne i materiali. Fu allora che, nel conforto di un traguardo finalmente raggiunto, Silvano alzò la testa e se ne rese conto.
Gigante, immobile, imponente e senza fine la parete gli apparve alla vista come un oceano da attraversare. Non si scorgeva in realtà la fine, perché dopo una verticale di qualche centinaio di metri, la cima curvava verso l’interno e lasciava intravvedere uno squarcio di cielo. Per quel che percepiva avrebbe potuto proseguire all’infinito. Si sentì, è retorico dirlo, come una formica. Anzi, ancora più piccino, confrontando l’enorme abilità di quella bestiola nell’arrampicarsi. Non aveva certo quella velocità. Ripensò alle storie di bivacchi in parete che aveva letto e si chiese come sarebbe stato. Erano soli in quell’immensa cattedrale di roccia. Solo l’aria fresca della quota e il gracchiare dei corvi. Nessuna voce urlante come accadeva nelle affollate vie dell’estate. Settembre garantiva la mistica solitudine dell’alpinista. E religiosamente, con umile rassegnazione si affidò ai voleri di quella potente divinità che appariva del tutto indifferente ai suoi turbamenti. “Tutto bene?” chiese il compagno cogliendo l’indugio. “Benissimo” fu l’ipocrita risposta che intendeva riacquistare la sicurezza del buon secondo di cordata. “I primi tiri dovrebbero essere abbastanza facili, poi ci sarà la traversata che è il passaggio più duro della prima parte.” Illustrò Andrea dopo aver ripassato la guida del Berti, aperta dal segnalibro che avevano lasciato la notte prima. Il dito di Andrea mostrava ora il percorso su quel disegno che sembrava così chiaro ieri, ma che ora Silvano faticava ad individuare sul corpo vivo della roccia.
“Ci sono già dei chiodi per la sicurezza, ma ne abbiamo anche noi” affermò Andrea facendoli tintinnare mentre li estraeva dallo zaino. “Se dovessimo usarli tu li devi recuperare col martello che ti ho dato. Ti ricordi come si fa? Un colpo da una parte e uno dall’altra.. poi lo agganci col moschettone.. Ma non credo che servirà.. è una via classica.. sicura.” Silvano ascoltava in silenzio sorseggiando dalla borraccia un po’ d’acqua. Si rese conto che doveva risparmiarla per la lunga arrampicata. Avrebbe voluto berla tutta d’un fiato tanta era la sete del momento. Riacquistò il ruolo di affidabile compagno. Cominciarono il rito della revisione del materiale, chiodi, moschettoni, cordini, martello. Quella musica tintinnante che, come il magico pifferaio, lo aveva incantato la prima volta che si era avvicinato ad una parete di roccia, scoprendo le umane macchie rosse aggrappate ad una fessura. Le voci urlanti si alternavano ai suoni metallici espandendosi come un coro nella valle.
Seguì la vestizione della corda. La Sicurezza. Una cintura che ora apparirebbe molto primitiva, accompagnata da una sorta di bretelle per distribuire lo strappo in caso di caduta. Il nodo bulino bello stretto e confermato dalla sicura. I moschettoni appesi come cartucce del pistolero. E questa volta pure il martello a rinforzare l’emozione di una investitura come vero rocciatore.
Partirono e subito riacquistarono fiducia. La legge del fare. Il pensiero turba sempre nell’attesa. Propone micidiali miscele in continuazione. Dubbi assillanti, come prima dell’interrogazione d’esame, quando credi di non ricordare più nulla e ossessivo ti ripeti: “E se mi chiede quello? E se mi chiede quell’altro?”. Così sfinito quasi ti arrendi, convinto che non ce la puoi fare. Dopo la porta si apre e vai. La realtà ritrova la misura. Talvolta anche un po’ di culo. Insomma, nella battaglia la disperazione smuove le sue arguzie, il mestiere ed anche se non pare possibile, la tua abilità.
Le mani sulla roccia di nuovo iniziano a parlare. Raccontano la certezza della presa, scoprono strisciando l’innesto vantaggioso. I piedi bilanciano la danza con passi alternati secondo la regola del tre. Un arto in movimento, gli altri tre in sicurezza. E scopri che la fatica è lieve se armonizzi il contrasto delle leve. Una danza gentile ed elegante. Come quella che Silvano osservava da sotto, mentre Andrea progrediva ispirando il percorso. Ora era molto concentrato nelle manovre di sicurezza. Faceva scorrere la corda dal nodo mezzo barcaiolo che fungeva da ipotetico arresto in caso di caduta. Doveva evitare che per qualche motivo si inceppasse, infastidendo i movimenti del capocordata. Era importante che arrivasse al primo chiodo. Fino ad allora, la corda non sarebbe servita a nulla.
Finalmente Andrea si era fermato, aveva agganciato il moschettone al chiodo e poi, con quel movimento che sempre lo aveva affascinato, aveva recuperato la corda dopo aver ordinato “Dammi corda!!” Quindi aveva preso l’eccedenza fra i denti per consentire al braccio di allungarsi fino a portarla sopra l’anello di ferro e spingerla con le dita per sentire il metallico “click!” della molla di chiusura. Salvezza raggiunta. Ora era in sicurezza. “Recupera!” fu il classico urlo di conferma.
Tra breve sarebbe toccato a lui. Non appena Andrea avesse trovato la piazzola di sosta con il secondo chiodo dove respirare con calma. Allora avrebbe sentito di nuovo l’urlo: “Dammi corda!! Sono arrivato!”. Avrebbe dovuto quindi essere veloce a staccare la corda dal moschettone, perché sarebbe stata recuperata in fretta. Era già successo altre volte, non era stato pronto e lo strappo aveva bloccato il moschettone. Stavolta doveva fare in fretta, non serviva ribadire il concetto che ormai era chiaro: erano partiti in ritardo.
“Recupera!!” urlò con decisione dopo aver agganciato il moschettone alla finta imbragatura e dato uno sguardo alla piazzola per vedere di non aver dimenticato nulla. “Vengo!!” ribadì perché fosse chiaro. Preferiva avere una corda bella tesa davanti. A parte la sicurezza che dava, quasi lo aiutasse a salire, c’era la difficoltà di gestire un anello floscio davanti a sé, che talvolta veniva ripreso a strappo proprio quando dialogavi con un appiglio sottile, in equilibrio precario. Aveva quindi imparato a sollecitare la tensione con una certa frequenza. “Recupera!!” la cadenza ravvicinata dava anche un’oggettiva valutazione della sua velocità.
E’ vero non si fidava ad arrampicare da primo, ma come secondo davvero non era male. Forte, veloce, mai ansioso. Cercava di facilitare le manovre e non si piangeva mai addosso. Anche quando la situazione era poco allegra. Andrea nel tempo imparò a conoscerlo ed ebbe a dire più avanti, ad una cena di amici rocciatori: “Quando Silvano canta, vuol dire che il passaggio è duro”. In effetti, era il suo modo di esorcizzare la tensione. Canticchiare o fischiettare fingendo agli altri, ma soprattutto a sé stesso, che non c’era nulla da temere. Per ora non ce n’era bisogno. La roccia offriva una bella presa alle mani e i piedi trovavano facili appoggi, seppure un po’ lucidati dai mille passaggi. Raggiunse il primo chiodo, sganciò rapido il moschettone che tintinnò lesto con gli altri alla cintura, poi riprese la salita seguendo la corda che deviava sulla sinistra.
“Vengo!” urlò di nuovo, procedendo verso uno spuntone dietro al quale si intuiva la figura del compagno. In un attimo fu da lui. Stretti nella piazzola che dava comunque un senso di sicurezza. Si agganciò al chiodo e riprese le manovre della sicura. Andrea era già ripartito. Non si erano detti niente, perché volevano nascondere la verità che li angustiava. Si limitarono a fare il più presto possibile.
Proseguirono in verticale per altri tre, quattro tiri. L’ascesa si rivelava agevole e gli appigli solidi favorivano la progressione. Alle spalle, la mole colossale della cima grande copriva integralmente la vista. Restava solo visibile il fondo, ormai confuso dalla dorsale che nascondeva il punto di attacco qualche centinaio di metri più giù. In alto la parete si faceva molto ripida e liscia. Silvano cominciò a osservarla con apprensione, come si poteva salire su quelle placche gialle e grigie che denunciavano una liscia verticalità?
“Ecco, ci siamo – annunciò Andrea – da qui bisogna attraversare.” Non serviva una spiegazione tecnica, era evidente e in qualche misura confortante. Sulla sinistra apparivano chiari i primi spuntoni sui quali agganciare le mani per procedere lateralmente. Sopra, la montagna si dichiarava sfrontatamente inespugnabile, con un’autorevolezza senza discussioni. Nella sosta cominciarono ad attrezzare la sicurezza, preparando un facile scorrimento della corda.
Le traversate hanno una loro caratteristica frizzante. Specie per il primo di cordata. Se scivoli o perdi l’appiglio prima del chiodo intermedio, oltre al volo è assicurato anche un bel pendolo. Ciò aumenta vertiginosamente il rischio di farsi del male sbattendo contro qualche sporgenza, ma soprattutto mette a repentaglio anche la tenuta dei chiodi di sicurezza, che vengono particolarmente sollecitatati dalle trazioni laterali ripetute. Insomma, meglio non scivolare e prima si arriva al chiodo meglio è.
Andrea consultava nervosamente la guida del Berti “Sono presenti due chiodi!” Concluse quasi per sfinimento “Speriamo non siano troppo lontani.” Aggiunse, cominciando a sporgersi per vedere se riusciva a scoprire dove fossero impiantati. La curva della parete non aiutava l’esplorazione. Dopo una quindicina di metri la roccia curvava verso l’interno, impedendo la vista del seguito. “Vado!” Andrea si mosse con concentrata decisione.
Il dialogo muto tra i due proseguiva complice. Bisognava accelerare senza indugi, ma sarebbe stato meglio capire dove si trovava il chiodo. La traversata aveva diverse prospettive percorribili anche più in basso e sbagliare la linea voleva dire perdere di vista la prima base. Silvano facilitava con cura lo scorrimento della corda. Non doveva esserci il minimo impedimento, ma bisognava anche tenerla limitata per evitare, nel caso peggiore, uno strappo violento. L’aria saliva dalla parete, portando talvolta voci lontane. Dalla Cima Grande qualcuno saliva per la via normale, facile, si diceva, ma lunga, lunga, lunga. In alto, lo squarcio di cielo azzurro chiuso dalle piramidi di pietra, cominciava a mostrare la rincorsa di nubi bianche e grigie.
“Non lo trovo!” Fu il primo segnale che venne ormai da dietro la curva di pietra. Poco dopo si sentì “Recupera!” e, mentre Silvano eseguiva con accuratezza la manovra, da dietro lo spuntone apparve la testa di Andrea. “Non mi fido… dovrebbe essere qui ma non lo vedo… Io impianto un chiodo qui dietro e poi lo recuperi!”
“Va bene.. Tranquillo che ti tengo.” Che altro avrebbe potuto rispondere Silvano. Il film si faceva ormai molto realistico. Era quasi come aprire una via nuova. Ma nell’entusiasmo un po’ fanatico, si faceva breccia anche una razionale incertezza sull’esito dell’operazione. Bisognava fidarsi. In fondo era tutto un poggiare su certezze molto aleatorie. Anche la roccia su cui erano avrebbe potuto cedere, oppure bastava uno solo di quei sassi volanti che i tedeschi annunciavano con qualche istante di ritardo ”Zazzsu!!” per chiudere la partita (All’epoca il nostro casco era il cappello di lana). Tutto è rischioso in parete. Anche i dubbi, specie se cominciano a corrodere la decisione dei movimenti. Quindi, nessuna incertezza. Andrea sapeva quel che faceva e l’aiuto vero era coordinarsi col capocordata senza discussioni.
I colpi ripetuti rimbalzavano con l’eco della parete vicina. Si poteva quasi vedere il chiodo che penetrava nella fessura di roccia. Bastava seguire il tono del suono metallico che finì, come nelle recite dei manuali, in un bel trillo definitivo. Si capì anche dalla richiesta di Andrea “Corda!!”, immediatamente esaudita, per permettere l’aggancio al moschettone. Respiro di sollievo. Erano in sicurezza. Tutto però avveniva ormai senza vedersi. La corda scorreva agevolata dalle mani di Silvano che cercava di percepire la minima richiesta, pronto allo strappo se mai ce ne fosse bisogno. Dalla velocità dello scorrimento, caratterizzato da alcune pause, Silvano capì che il compagno stava ancora cercando il chiodo originale. Ricerca fallita. Poco dopo, un nuovo urlo, più lontano “Ne pianto un altro!!” Poi ecco i colpi del martello che ricantava il suo ritornello. Stavolta la breccia doveva essere più stretta, perché il concerto fu più lungo e il finale quasi rabbioso. Anche il canto, benché professionale, appariva un po’ sfiancato, come un tenore all’ultima replica.
“Vadoo!” Ribadì il capocordata con un urlo che doveva aggirare la roccia, per arrivare attutito alle orecchie del compagno che aspettava novità. Il mulinello della corda riprese. Stavolta con qualche strappo volontario. Andrea si preparava un po’ di lasco prima di affrontare un nuovo passo. La corda scorreva a fatica lungo i rimandi dei moschettoni, strisciando sulla roccia che curvava e ormai ne rimaneva poca. Una bella traversata, pensò Silvano, mentre calcolava che ormai se ne erano andati più di una trentina di metri. Poi tutto si fermò e la voce che lo chiamava “Dai, vieni!” non fu che una conferma di quanto aveva immaginato. Andrea lo aspettava in sicurezza alla sosta. Ora toccava a lui.
Prima di partire si assicurò di avere facile agibilità del martello che era appeso al fianco. Avrebbe dovuto staccare i chiodi. Era la prima volta e, una volta tolto, il pendolo stavolta era una minaccia sua. Comunque si rischiava da subito e quindi fu molto concentrato nel progredire secondo gli schemi scolastici. Un, due, tre – uno – un, due, tre – uno. Mentre eseguiva, compiaciuto dal trovare ogni volta appigli e appoggi adeguati, si convinceva sempre più che l’arrampicata era una danza ritmata di contrappesi e opposizioni, che nella migliore interpretazione era un elegante gioco di inganno con le leggi di gravità. La forza veniva utilizzata per vincere se stessa. Un gioco di prestigio, in cui contava soprattutto la sfrontatezza di abbandonare l’abbraccio del corpo alla roccia. Più ti spingevi fuori e più aumentava l’aderenza. Un paradosso che i neofiti stentano ad accettare.
Arrivò al chiodo e si accorse che gli appoggi su cui sostare non erano agevoli. A sinistra aveva una bella presa per la mano, una maniglia nel gergo montanaro. Ma per i piedi c’era solo una sottile cornice di qualche centimetro, anche leggermente inclinata verso il basso. Insomma la sua prima estrazione presentava al dentista il dente del giudizio. Lo confermò il suono ribelle del chiodo che, appena liberato dal moschettone, cominciò a urlare infuriato sin dal primo colpo. Era ben conficcato in una stretta fessura e risputava con violenta elasticità ogni colpo di martello. Il rimbalzo spostava il corpo, costringendo alla presa aggressiva alla maniglia. Una manovra faticosa e pericolosa. Provò a colpire lateralmente. In un senso la manovra risultava agevole, ma quando doveva colpire verso il braccio che esercitava la presa, il colpo diveniva naturalmente meno convinto per il rischio autolesionistico. Il chiodo comunque manifestò quell’ostinato carattere da alcuni ritenuto perfino una qualità. Mi piego, ma non mi spezzo. In questo caso, mi piego non mi muovo, perché anche il tentativo di lavorarlo in trazione con un moschettone e un cordino si rivelò fallimentare. Nessuna resa.
“Lascia stare! Lascia stare! Vien vanti che semo in ritardo!!” Il richiamo di Andrea fu insieme una liberazione ma anche una delusione. La battaglia col chiodo era perduta e nessuno saprà mai se fu per impossibilità o incapacità. Comunque l’invito era ragionevole. Se si fossero attardati ancora, sarebbe divenuto tutto più incerto, compresa la ritirata lungo la via di salita, meno rapida della discesa in doppia che li aspettava dall’altro lato. Finalmente poi si dichiarava il sottaciuto implicito di quella gita. Non si poteva più fare finta di niente: erano in ritardo, al limite delle possibilità di chiudere in giornata la salita. Qualunque imprevisto avrebbe determinato una seria complicazione.
Silvano avanzò deciso. Un po’ per confortare il nervosismo che aveva percepito nel richiamo di Andrea, un po’ per allontanarsi da quel fallimento che il peso dell’inutile martello appeso alla cintola gli ricordava sfottente. Rimase concentrato, perché la precauzione del secondo chiodo non era stata esagerata. Qualche passaggio offriva appoggi bonsai e cominciò a pensare che la ricerca dei vecchi chiodi assenti testimoniava che avevano preso una variante. Giunto al secondo chiodo, fu incoraggiato dal richiamo di Andrea “Dai! Lascia perdere!” che risolse i suoi dubbi. Anche quel ferro lucente sarebbe rimasto a futura memoria. Sganciò il moschettone e proseguì rapido verso il compagno, che ora poteva vedere bene ancorato in un terrazzino. Quando lo raggiunse, si accorse che era davvero stupito di non avere trovato la via. “Forse siamo passati troppo bassi…Non capisco…Mi pareva logico venire di qua…Ma nessun chiodo e anche..” “Più duretta del previsto!” Suggerì Silvano, con un mezzo sorriso. “Sì, sì… va bene – interruppe Andrea – Ma ci abbiamo messo troppo tempo. Adesso bisogna accelerare.” Si capiva che stava montando la preoccupazione. Erano solo ad un terzo del percorso e già l’arrampicata aveva perso quella dimensione scanzonata e un po’ folle delle vie precedenti. Qui l’austerità della piramide, la sua mole imponente, la solitudine tra le due grandi pareti grigie, il residuo triangolo azzurro di un cielo che si faceva plumbeo, l’inesorabile denuncia dell’orologio, quel misterioso inceppo del percorso, tutto dichiarava esplicitamente che il gioco si faceva serio e che bisognava darsi da fare.
Il capocordata partì determinato a recuperare minuti preziosi. La corda scorreva rapida tra le mani del secondo, che aveva rinunciato al conforto di un po’ d’acqua e cibo per favorire la veloce ripresa delle operazioni. Fu altrettanto lesto nell’abbandonare quella comoda postazione e risalire. La corda sembrava quasi richiamarlo ogni volta che in un passaggio indugiava un attimo per capire la perfezione dell’appiglio. Era come una prolunga delle braccia dell’amico, che lo sollecitava a fare presto. Così fece. Il sudore cominciava a scorrere lungo la schiena e anche le mani divenivano dolenti. Erano tornati certo nella corretta via, ma il ritmo accelerato aumentava le difficoltà. Poca conversazione, solo le solite frasi chiave per comunicare le operazioni. Silvano, oltre al respiro che diveniva corposo, poteva udire allora la voce della montagna. Quel suono strano e indefinibile che confonde le correnti d’aria, lo stridio dei corvi, la caduta di un sasso, lo sfarfallio del collo della camicia sotto l’improvvisa raffica, quella maestosa silente e insieme imponente voce che pare dire sono qui da millenni e tu ricordati di non disturbare. Silvano pregava, come al solito, con quella forma laica di invocazione che consiste nello stare dentro al fluire senza chiedere spiegazioni. Il movimento dell’arrampicata aiuta in questo rituale zen che consiglia il non fare. Lascia che ci pensi la saggezza del tuo corpo, abbandona la mente agitata. Salire servirà a confermare simbolicamente la conquista meditativa. In alto, all’improvviso ti ritrovi in alto e l’aria frizzante lancia il tuo sguardo nei panorami lontani. Quello che ti appariva grande è ora un pulcino nel paesaggio disegnato lì sotto, dove scorre la vita d’affari e tormenti che ora, da qui appare piccola e ridicola. Da qui, puoi finalmente sentire il respiro delle cime.
Sul grande terrazzo, quasi un ballatoio, erano giunti provati. Era stata una corsa, non dichiarata, ma complice e accelerata. In pratica non c’era mai stata sosta. Nei punti di sicurezza, c’erano stati solo gli scambi necessari alla prosecuzione. Come il passaggio di consegne tra sentinelle, con quelle che hanno finito il turno, desiderose di non perdere un istante. Rispettate le misure di sicurezza, si ripartiva, quasi senza fiatare. Una procedura che comunque aveva recuperato qualcosa nel rollino di marcia. Ora, gli abbondanti spazi della sosta e la verticale parete che annunciava gli ultimi tiri di corda prima della cima, imponevano una pausa di conforto e anche di riflessione. Finalmente si mangia, pensò Silvano, cercando nello zaino anche quella cioccolata che non aveva solo una funzione energetica. Serviva un po’ d’incoraggiamento. Li aspettava il camino. Quel passaggio su cui aveva a lungo discusso nell’incontro preparatorio. Era il punto più aereo, più difficile forse, ma anche il più bello della via. Quella tecnica speciale che Silvano non aveva mai sperimentato e che lo aveva sempre ingolosito, osservando i film di ascensioni. Il miracolo di sostenersi nel vuoto puntando gli arti in opposizione, con un’eleganza che ispirava i registi in controluce. Era uno dei motivi per cui aveva concordato entusiasta con Andrea la scelta del percorso. E poi, così difficile? Se ce l’aveva fatta il grande Innerkofler, con tutti i riguardi, si trattava comunque del 25 luglio 1881, quasi un secolo prima. Nell’ingenuità giovanile quasi offensiva, la distanza del tempo garantiva il risultato. Silvano lo capì solo molti anni dopo, quando, in preparazione al Cervino, con la guida Peretti affrontò la via Preuss, sulla Piccolissima di Lavaredo. Difficoltà e bellezze senza tempo.
Osservavano il primo tiro. Non sembrava così agevole e il camino si scorgeva a stento ancora più su. Ciò che però intimoriva era ancora più in alto, nello squarcio di cielo che si intravvedeva. Nuvole pesanti si rincorrevano, accompagnate da folate di vento freddo e da una nebbiolina capricciosa che li avvolgeva per un istante, per poi risalire rapida dopo aver fatto capire come sapeva gelare il sudore sulla schiena. Silvano bevve l’ultimo sorso, lasciando una lacrima nella borraccia (Bisogna tornare sempre con un po’ d’acqua, non si ricordava se era una regola da manuale o se era una sua invenzione per contenere l’avidità). Si chiedeva come avrebbe fatto a resistere fino al rifugio e fu in quel mentre che Andrea parlò: “Dobbiamo decidere – Era serio e quasi sofferente nel pronunciare le parole – Abbiamo recuperato un po’… forse possiamo farcela… ma anche il tempo mi pare incerto… è brutto ma…” “Forse è meglio fermarci?” Suggerì Silvano, cogliendo la fatica del capocordata nell’imporre una scelta che sapeva un po’ di sconfitta, specie in un’età in cui è difficile essere ragionevoli. “Se vuoi possiamo tentare – continuò Andrea – ma bisogna essere molto rapidi e poi…” “Per me possiamo tornare – ribadì il compagno – è stato bello fin qui … e al camino tornerò un’altra volta!” Silvano aveva capito il travaglio di Andrea che era anche il suo. Ma lui non aveva paura di avere paura. Era anche troppo prudente a volte, ma nessuno conosceva bene lo sforzo della sua arrampicata. Quel terrore panico del vuoto, quello che aveva vinto volontariamente, arrampicando. Quello che ritornava nell’incubo ricorrente, adolescenziale di precipitare nel vuoto o di vedere precipitare persone che amava. Quello che gli suscitava un violento paradosso fisico, ogni volta che si sporgeva sulla verticale dell’abisso. Una scossa che partiva dagli occhi, attraversava la nuca, scorreva davanti allo stomaco togliendo il fiato e si lanciava fino in fondo alle ginocchia, che un po’ si piegavano tremanti. Poi la sensazione risaliva, portando in evidenza il motivo di tanto terrore. Avrebbe voluto lanciarsi come attirato dalla calamita del fondo. Era questa angustiante tentazione che contrastava con lo spaventato istinto di sopravvivenza. Una battaglia che si rinnovava ogni volta, anche se l’esperienza, l’allenamento, la tecnica e la fiducia nel compagno ne attenuavano la dimensione.
“Va bene, allora torniamo” Confermò Andrea, come liberato da un peso. Anche Silvano si sentì sollevato. Era da un po’ che si chiedeva se era opportuno continuare. Come sempre il bilico tra due scelte provoca facilmente una nevrosi che accumula tensione. Ora che la decisione era presa, l’energia si scaricò e trovarono anche modo di scherzare mentre preparavano la corda per la doppia. Quasi a conforto del loro orgoglio ferito (non pensate che sia stato così facile rinunciare) le nuvole cominciarono a infittirsi e la montagna fece sapere che i suoi tempi sanno essere molto più veloci delle previsioni. Ora a tratti si trattava proprio di nebbia gelata che cancellava dispettosa le curve avvolte in un’unica nube.
Arrivarono in fretta al primo chiodo cementato per la doppia. Dovettero fermarsi perché cominciava a nevicare. Cristalli pungenti s’impiantavano a raffica sulle rocce e penetravano quasi la flanella della camicia. Indossarono le giacche prudentemente in dotazione. Un buon conforto che dovette essere accentuato anche dal berretto di lana abbassato a coprire le orecchie. A tratti pareva bufera. Non c’era da indugiare.
“Io vado – annunciò Andrea sporgendosi nel vuoto – Fai presto perché se la neve copre i chiodi siamo fottuti… dopo non sappiamo dove trovarli. Presto!” Fu la sua ultima raccomandazione, mentre spariva divorato dal vuoto e dalla nebbia che accolse il suo tuffo. Silvano osservava la corda tremante, che pulsava ad ogni salto nel vuoto del compagno. Ripassava le manovre da fare appena fosse stato il suo turno. Voleva rispettare le consegne.
“Dai!! Vieni!” Fu il richiamo cui rispose appena ebbe intrecciata la corda dietro la schiena, tra lo zaino e la mano sinistra che faceva da freno. “Vengoo!!” E via quel salto liberatorio che ti fa sentire amica la forza di gravità controllata. Che bello spingersi con i piedi sulla parete e compiere balzi frenati! La prima volta che aveva fatto una doppia, sulla via delle guide al Falzarego, aveva pensato che solo quella valeva la fatica dell’ascesa. Ora però doveva pensare ad essere prudente e veloce. Quella giacca imbottita tendeva ad arricciarsi sotto la frizione della corda che la trascinava ed una volta era quasi arrivata al moschettone. Se passava dall’altra parte, avrebbe bloccato lo scorrimento, aveva pensato, mentre atterrava nello stretto terrazzino dove lo attendeva un nervoso capocordata.
“Devi essere più veloce – redarguì Andrea – Ormai nevica davvero e se mi copre il chiodo… Qui diventa più verticale, se non le vedo e passo via, dopo come faccio a risalire?” La neve, in effetti, aveva preso coraggio e i fiocchi gonfi che si mescolavano alle schegge ghiacciate, trovavano facile terreno di presa, trasformando il paesaggio puntuto degli appigli in un bianco tutto tondo. Perfino il chiodo cui erano assicurati, in un attimo perdeva la sua evidenza e tornava confuso tra la roccia. Aveva ragione, bisognava fare presto, anche per quello che li aspettava più avanti, quando finite le doppie, avrebbero dovuto camminare in uno stretto, franoso, sentiero sull’abisso. “Vado” E Andrea di nuovo sparì. Ci sono momenti in cui sei solo in montagna e sei costretto a fare i conti con i tuoi limiti. Quei pochi minuti in cui Silvano rimase in attesa del via, sferzato dal vento e dalla neve, appeso in una parete deserta, avvolto da una nebbia fredda che accentuava il primo buio della sera, pensò che davvero potevano essere in pericolo e che doveva essere veloce.
Lo fu. E forse questo fu il suo errore. I balzi prolungati guadagnavano terreno, ma sollecitavano di più l’attrito che infine trascinò con la corda, come temuto, oltre il moschettone il tessuto di nylon della giacca, creando un groviglio che impediva lo scorrimento. Era bloccato, sospeso nel vuoto. Eccoci tornati all’inizio del racconto.
Non c’era troppo tempo per riflettere. Un vantaggio, perché l’ansia cresce nell’immobilismo, quando la mente ha modo di fantasticare tutte le più tragiche eventualità. La voce implorante, forse un po’ insultante del capocordata risaliva la nebbia e tra i fiocchi di neve stimolava l’azione. Poche chance. Solo contare sulla forza delle braccia. Bisognava risalire con le braccia, appese per un po’ lungo la corda, lasciando ogni sicurezza. Poi, mentre con la mano destra si doveva sorreggere tutto il peso, la sinistra doveva lavorare per liberare il groviglio dal moschettone. Inutile pensare cosa sarebbe successo se non ce l’avesse fatta. Doveva riuscire e anche in fretta. C’è chi dice scientificamente che è l’adrenalina. Altri più esotici parlano dei poteri sconosciuti della mente. Per Silvano forse fu più semplicemente la paura a dare la forza sorprendente con cui avviò la manovra. Fu così rapido e deciso, che gli parve perfino eccessivo il timore che lo aveva percorso un attimo prima. Il piano si rivelò efficace. Il braccio destro riuscì a tenere tutto il peso sospeso, mentre la mano sinistra, senza troppe cortesie, strappò via il nylon della giacca che ritornò rapida alla spalla. Una ferita da cui usciva della bianca ovatta, denunciava il rischio corso. Un attimo dopo Silvano era di nuovo in posizione corretta e sicura. Scese, stavolta senza esagerare e l’emozione era ancora così forte quando atterrò vicino ai piedi del compagno, che non ebbe la forza di reagire agli insulti, spiegando l’accaduto. Andrea aveva ragione. Nevicava fitto e la nebbia avvolgeva ormai tutta la montagna. Si scusò e cercò di agevolare i movimenti del compagno che un attimo dopo, sempre brontolando, sparì nuovamente nella nebbia.
Le doppie proseguirono senza intoppi, ma presto finirono e cominciò la passeggiata in discesa tra sfasciumi. Forse era quella che più temeva Silvano. Quando la nebbia si diradava dando maggiore possibilità di stabilire la rotta, contemporaneamente si evidenziava il rischio di uno scivolone che poco sotto sarebbe stato ingoiato dal salto verticale. Ad ogni piccolo slittamento dei frammenti sotto le suole, Silvano ripensava alle storie dei grandi alpinisti che, dopo aver conquistato superbe vette con vie estreme, erano scivolati nel più banale dei sentieri. Anche la sua sarebbe stata una fine senza gloria, diversa dalla caduta in parete che suscita rispetto. La nebbia poi si divertiva a stimolare la tensione, richiudendo rapida la visione panoramica che aveva aperto, riportando tutto all’indistinto di solo qualche metro. Si andava un po’ a tentoni, giustamente slegati, perché non ci sarebbe stato modo di trattenere il compagno. A ciascuno il suo destino. La sera cominciava la sua conquista e benché la quota garantisse qualche chiarore in più, l’ombra scura aggiungeva una malinconica riflessione. Camminavano in silenzio, ognuno chiuso nei suoi pensieri.
Si trovarono alla fine del percorso quasi senza accorgersene. D’improvviso finiva il salto verticale e la montagna generosa concedeva il comodo sentiero delle passeggiate in alta quota. “E’ fatta!” Dichiarò Silvano, senza pudore e Andrea sorrise complice, senza aggiungere nulla. Tornava il buonumore che si evidenziava nei passi ampi e veloci, favoriti dalla discesa.
La incontrarono all’incrocio del sentiero che portava all’attacco della via comune per la Grande. Una bella signora bruna, forse quarantenne, trafelata. Si avvicinò quasi correndo e comunicò in tedesco, che poi divenne inglese, che poi divenne gestuale e chiaro. In due erano saliti lungo la via e ancora non erano tornati. Avrebbero dovuto essere già lì, ma per il momento nessuna traccia. Chiamava, ma non rispondevano. Non sapeva più che fare. Neppure loro. Non erano certo in grado di salire in soccorso e l’unica opzione era di correre al rifugio e avvisare le squadre del soccorso alpino. Così fecero, dopo averla tranquillizzata, col loro sbilenco eloquio, insistendo sul fatto che era una via lunga e presto sarebbero tornati.
Il gestore del rifugio se ne fece carico brontolando che li aveva avvisati. Troppo tardi per salire la Grande. Dopo il tè caldo ci fu pure la grappa al mugo, prima di ritrovare la fedele Prinz che li aveva attesi nel grande spiazzo. Partì subito, con il suo fruscio da frullatore esagerato. I fari accesi contrastavano con gli ultimi bagliori di un tramonto che la nebbia aveva abbandonato, creando l’atmosfera di un finale cinematografico.
Parlarono d’altro. Dei nuovi progetti per i prossimi giorni e scherzarono anche sorridenti. Ogni tanto tornavano col pensiero alla signora e nel loro cuore partiva un’invocazione solidale perché non finisse male. Silvano pensò che quel giorno, nella sconfitta erano anche maturati. Che forse quella rinuncia, logica e motivata, ma anche difficile da digerire e da raccontare, li aveva trasformati.
Guardò Andrea sorridente e seppe che sarebbero stati amici per sempre.
La giacca fu riparata dall’arte magistrale della mamma sarta. Due pezze di pelle che la rendevano perfino più funzionale nel trasporto invernale degli sci. Per anni Silvano, non seppe liberarsene, quasi fosse un totem del percorso iniziatico. Quando infine fu depositata, a fine carriera, nei contenitori della Caritas, sperò che portasse fortuna come era accaduto a lui.
